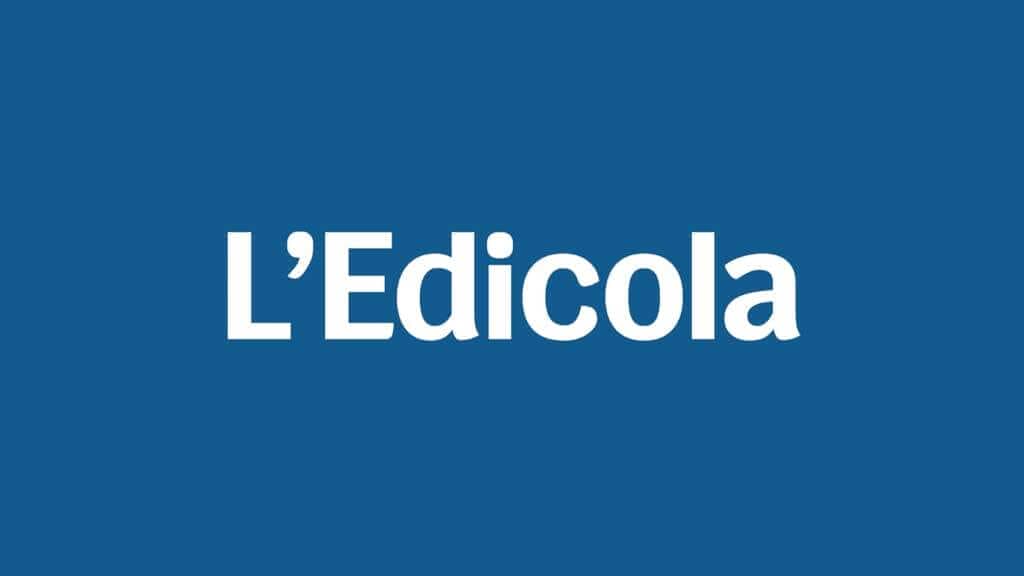Inquinamento di origine industriale che colpisce la città di Taranto. Intervengo con alcune considerazioni sulla ormai annosa e storica vicenda in virtù di una conoscenza del problema che si è sviluppata nell’arco di alcuni decenni: la prima sentenza con la quale i vertici dell’ltalsider di Stato vennero condannati per la diffusione delle polveri minerali sul quartiere Tamburi la pronunciai io, da giovane Pretore, nel lontanissimo anno 1982. Da allora si sono susseguiti tanti altri procedimenti penali per fatti via via sempre più gravi di inquinamento. Processi conclusisi quasi tutti con sentenze di condanna passate in giudicato. La situazione diventò sempre più grave, sicché si arrivò agli estremi dirompenti finali (processo Ambiente svenduto).
In quello stabilimento, quindi, insieme ai miei valorosi Colleghi, ho lavorato per oltre 40 anni e poiché tutti i procedimenti si basavano su perizie articolate e sempre più complesse, penso di avere maturato una certa conoscenza della problematica che – senza considerarmi dotato del dono della infallibilità – comunque mi consentono alcune considerazioni. Ed allora, comincio col dire che quell’impianto industriale è stato realizzato più di 60 anni fa, sulla base di una metodologia tecnica costruttiva e operativa antica e superata, tanto che oggi esso rimane un caso più unico che raro. Quell’impianto, quindi, in linea di massima nasce “inquinante”. Mi spiego meglio: l’inquinamento non era provocato da difetti di manutenzione, di controllo ecc. ma dalla sua struttura operativa: i parchi minerali, i nastri trasportatori dei minerali, le cokerie, l’impianto di agglomerazione e così via “dovevano” necessariamente inquinare, cioè disperdere sostanze pericolosissime sia per la salute del personale dipendente, sia per i cittadini di Taranto e non solo del vicino quartiere Tamburi (che, va ribadito, esisteva già da alcuni decenni prima della costruzione dello stabilimento).
Voglio precisare, riportando le valutazioni peritali che si desumono dalle relazioni tecniche di ufficio depositate nei vari procedimenti: un impianto del genere può funzionare con un ridotto tasso di inquinamento solo se si attesta sua una produzione di non più di 4 milioni di tonnellate di acciaio l’anno. In tal caso, però, o fallisce, o deve ridurre la massa lavorativa a non più di 4.000 dipendenti (circa 1.000 per ogni milione di tonnellate). Per raggiungere il pareggio di bilancio, invece, l’impianto dovrà produrre almeno 8 milioni di tonnellate di acciaio l’anno e, in tal caso, mantiene anche i livelli occupazionali ma inquina inevitabilmente. Questi sono i termini del problema, senza bisogno di ricorrere a giri di parole.
Che fare allora? La scienza e la tecnica moderna hanno radicalmente modificato il sistema produttivo siderurgico, sicché in tutto il mondo vi sono impianti siderurgici anche enormi addirittura all’interno di centri abitati perché questi, essendo stati realizzati sulla base delle più moderne tecnologie, non provocano più dirompenti effetti negativi.
Che fare a Taranto? L’alternativa, a parer mio, è la seguente: trasformare il ciclo di lavorazione siderurgica creando un impianto moderno e al passo dei tempi. Sento parlare di soluzioni difficili (de-carbonizzazione, forni elettrici e così via ) la cui attuazione comporterebbe quindi esborsi economici iperbolici e di dubbia efficacia. In altri termini: quello stabilimento andrebbe demolito e ricostruito ex novo. Se poi si considera che la questione è esplosa ben 10 anni fa (ma tutti immaginavano anche da prima la realtà) e che oggi si parla ancora di “cosa fare”, ritengo vi siano motivi per essere estremamente pessimisti sul punto.
Altrimenti, se apriamo un qualunque manuale di Economia Politica e andiamo a leggerci il capitolo sulla “teoria delle esternalità”, ci viene spiegato che quando ci si trova di fronte ad una attività che ha pregi e difetti (il manuale in uso all’Università di Bari fa l’esempio di uno stabilimento siderurgico), bisogna pensare ad una bilancia a due piatti: su un piatto si depositano le “esternalità positive” (cioè i vantaggi che un’attività produce) e sull’altro le esternalità negative” (cioè gli effetti negativi prodotti da quella stessa attività). Se i due piatti rimangono almeno in equilibrio, la situazione è accettabile.
Veniamo quindi al caso di Taranto e del nostro impianto. Quali sono le “esternalità positive” dell’attività siderurgica in questione lo sappiamo bene: il contributo all’economia locale, sotto forma di stipendi, e il contributo all’economia nazionale, sotto forma di produzione di acciaio necessario per l’industria manifatturiera.
Cosa mettiamo sul piatto delle “esternalità negative”?
La realizzazione dell’impianto ha letteralmente distrutto la fiorentissima attività produttiva agricola non solo della zona degli impianti, ma anche di una enorme estensione aggiuntiva (vigneti, uliveti, agrumi, grano ecc.). Certo non si può sostenere che tali profitti avrebbero compensato le “esternalità positive”, ma una danno comunque c’è stato, e tale danno lo possiamo “mettere” sul piatto negativo della bilancia.
La realizzazione dell’impianto ha portato alla distruzione della piscicoltura e della molluschicoltura non solo nel mar Piccolo, ma anche nelle zone costiere esterne. Certo, i guadagni derivanti da tali attività non compenserebbero da soli le “esternalità positive”, ma comunque un quid di negativo c’è e va inserito nel relativo piatto della bilancia.
L’allevamento del bestiame è stato distrutto: ricordo ancora le tristi scene di centinaia e migliaia di animali macellati brutalmente perché le loro carni e i relativi prodotti caseari erano avvelenati. Certo… però (vedi sopra).
Il turismo in quelle zone costiere è stato annichilito: anche quella del turismo è un’industria, alla quale abbiamo dovuto rinunciare. Certo… però (vedi ancora sopra).
La salute e la vita: io non mi limito a parlare di un cumulo di sofferenze, di dolori, di disperazione che colpisce le nostre popolazioni, ma faccio anche un discorso economico: quanto costa economicamente questo enorme bagaglio di situazioni negative, in termini di terapie, di pensioni di invalidità? Certo… però (vedi sopra).
Ed ancora: quante centinaia di milioni, o, meglio ancora, quanti miliardi di euro costerebbe una trasformazione così radicale dell’impianto siderurgico che, come già detto, sostanzialmente andrebbe sfabbricato e rifabbricato? E vi sarebbero i margini di produttività per far fronte alla concorrenza spietata dei colossi internazionali della produzione siderurgica, che sono dietro allo sfruttamento delle miniere di minerali (che stanno distruggendo vasti territori dell’America latina) e al controllo delle flotte carbonifere, magari facendo affidamento su un sistema di dazi protettivi che non potrebbe resistere a lungo? Non è anche questa una esternalità negativa da porre nel relativo piatto della bilancia?
Quanto si potrebbe ricavare avviando una grossa percentuale dei dipendenti ex llva a lavori di bonifica e recupero del territorio, evitando repentini provvedimenti di licenziamento e consentendo poi un graduale pensionamento agevolato? E comunque, si potrebbe salvaguardare la produzione nazionale siderurgica perfezionando gli impianti non inquinanti attualmente operanti in Italia per evitare danni insopportabili.
E allora? Forse sarebbe il caso di affrontare questo enorme problema in maniera più approfondita e meditata: ma quando sento dire che occorrerà una decina di anni per sanare la situazione, quando sono già passati 10 anni dall’avvio del procedimento (l’indagine era nata molto prima), credetemi mi cadono le braccia.
Un’ultima precisazione: se quello stabilimento, nella sua attività abbia prodotto gravissimi reati ce lo dirà la sentenza definitiva. Ma che da quello stabilimento sia derivato e sussista ancora un disastro ambientale, ebbene, quello ce lo dicono una decina di leggi dello Stato, basate tutte sullo stesso presupposto e la lotta per il mantenimento dello “scudo penale”: ciò dimostra che quei danni sono già stati riconosciuti dal nostro Stato, che si basa su una Carta Costituzionale che sostiene che esiste un solo diritto non “contemperabile” con tutti gli altri diritti: parliamo del diritto alla vita, che non può tollerare compromessi e aggiustamenti di alcun genere: non si può morire “poco poco”!
Francesco Sebastio è stato Procuratore della Repubblica di Taranto