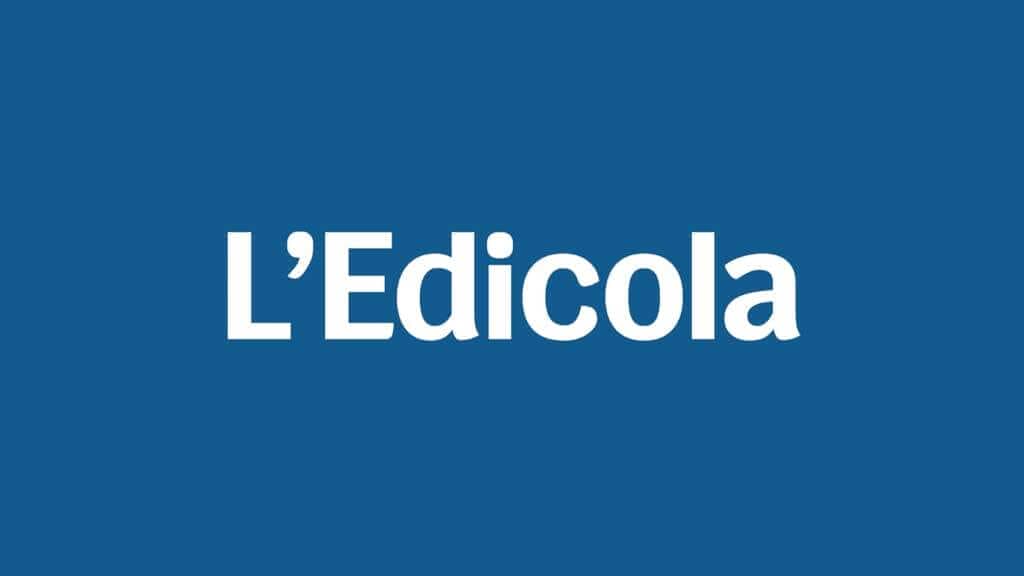La Puglia consolida la propria posizione tra le mete turistiche più ambite d’Italia, confermandosi un territorio in fermento, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri in cerca di autenticità, paesaggi incontaminati, cultura e sapori. Un trend che si riflette nella crescita esponenziale delle strutture ricettive: secondo i report della banca dati delle strutture ricettive istituita dal Ministero del Turismo, sono oltre 58.000 le realtà attive sul territorio pugliese. Una cifra che comprende hotel, bed & breakfast, case vacanze, agriturismi, campeggi, villaggi turistici e ostelli.
La distribuzione geografica premia la provincia di Lecce, capofila dell’ospitalità regionale, seguita da Foggia e Bari, a conferma di un interesse turistico ormai diffuso sia lungo le coste che nell’entroterra. Ma il dato più rilevante riguarda la composizione dell’offerta: è, infatti, il comparto extra-alberghiero a trainare l’espansione. Negli ultimi dodici mesi, questo segmento ha registrato un aumento del 18% rispetto al 2023, con performance particolarmente significative per bed & breakfast e case vacanze, che segnano un balzo in avanti del 20% rispetto a due anni fa.
In crescita anche gli agriturismi (+15%) e gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (+10%). Il successo di queste formule rispecchia un cambiamento strutturale nelle abitudini dei viaggiatori. Sempre più turisti prediligono soluzioni flessibili, indipendenti e immersive, che garantiscono autonomia, contatto diretto con la realtà locale e spesso un maggiore risparmio economico. Una tendenza che sta modificando l’equilibrio del mercato.
Le strutture extralberghiere
Le strutture extra-alberghiere stanno superando di gran lunga gli alberghi tradizionali, in particolare quelli di fascia media, che spesso faticano a mantenere tassi di occupazione competitivi. Tuttavia, l’espansione quantitativa del turismo pugliese pone anche nuove sfide strutturali. Una delle principali è rappresentata dalla carenza di infrastrutture adeguate, soprattutto nelle aree rurali e costiere, dove la crescita dell’offerta ricettiva non è stata accompagnata da un potenziamento dei collegamenti ferroviari, della viabilità interna o dei servizi essenziali.
Il rischio è quello di compromettere la qualità dell’esperienza turistica, oltre che la sostenibilità del modello di sviluppo. Non meno cruciale è il problema della stagionalità. L’afflusso turistico continua a concentrarsi nei mesi estivi, lasciando gran parte delle strutture ricettive inutilizzate durante l’autunno e l’inverno. La destagionalizzazione, insomma, resta una sfida ancora aperta, basata sulla necessità di fare leva su strategie di lungo periodo, capaci di coinvolgere enti pubblici, operatori del settore e comunità locali. Le potenzialità, del resto, non mancano.
La conferma arriva dai dati. Il patrimonio enogastronomico, la rete dei borghi storici, i cammini religiosi, così come il turismo scolastico e sportivo, rappresentano asset fondamentali per diversificare l’offerta e distribuire i flussi turistici su tutto l’arco dell’anno, superando una visione frammentata del turismo e puntando su programmazione e qualità. Perché l’ospitalità, oggi più che mai, non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di accogliere senza snaturare, di crescere senza consumare e di durare nel tempo.