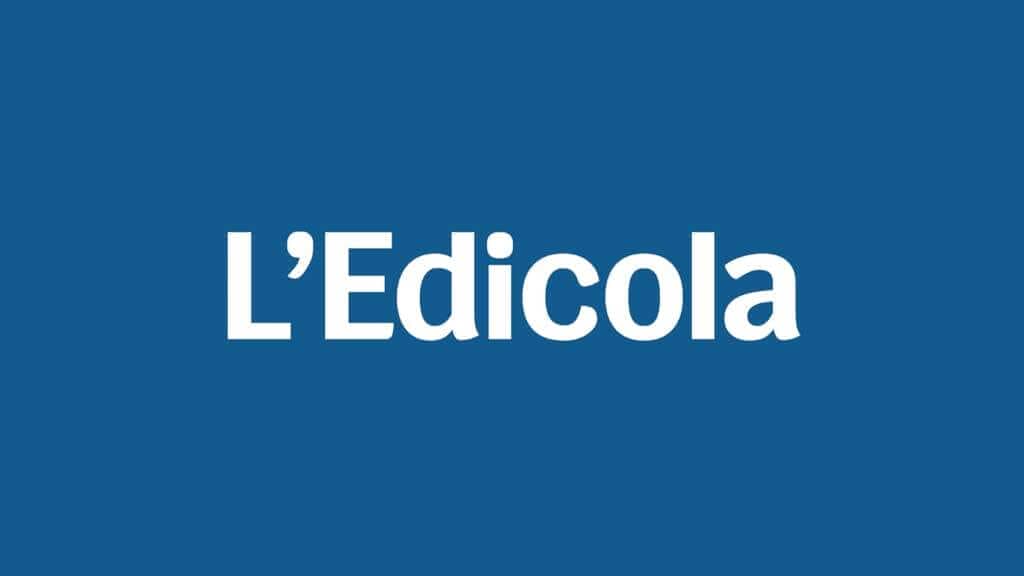Ci sono persone che sembrano nate per raccontare. Non per spiegare il mondo, ma per illuminarlo con la grazia del racconto. Vincenzo Mollica appartiene a questa razza gentile di narratori: per quarant’anni ha fatto entrare l’arte, il cinema e la musica nelle case degli italiani, come in una lunga storia d’amore.
Ora che la vista lo ha abbandonato, dice che le immagini gli arrivano dalla memoria e in quelle immagini si mescolano Mina e Fellini, Topolino e Totò, i fumetti dell’infanzia e i festival della maturità.
Tutto comincia da un’edicola di Formigine, dove un bambino curioso scopriva che i giornali profumano di storie e che la felicità, a volte, ha l’odore dell’inchiostro fresco.
Da bambino, qual era la sua felicità più grande?
«Mi piaceva andare ad aiutare i giornalai. Ero un ragazzino, a Formigine, in provincia di Modena: d’estate tornavo e passavo ore all’edicola della stazione, a “spaccare” i giornali. Meglio che andare al cinema. Mi affascinava tutto il gioco delle immagini, la loro potenza: “Il Corriere dei Piccoli”, “Topolino”, “Tv, sorrisi e canzoni”. Era come scoprire un mondo parallelo. L’edicola, per me, era il luogo da cui passava tutto: cultura, spettacolo, arte. Perfino il profumo era particolare: non solo carta stampata, ma anche giocattoli, dischi, libri».
Crede che le edicole resisteranno in futuro?
«Sì. Cambieranno forma, come tutti i negozi, ma resisteranno. L’edicola è anche l’edicolante: un “traghettatore di anime”, non solo di giornali. Sapeva tutto dei suoi clienti e proteggeva e diffondeva cultura. Al Sud, un tempo, ce n’era magari una sola a decine di chilometri di distanza: eppure era un presidio. Ho sempre sognato che gli edicolanti raccontassero le storie che hanno vissuto: contatti umani speciali. Da bambino mi mettevo accanto al giornalaio: mi dava “Topolino”, io leggevo e poi gli raccontavo la storia. Un allenamento alla fantasia».
Da lettore di Topolino a personaggio: si sarebbe mai aspettato Vincenzo Paperica?
«Mai. E invece ho avuto la fortuna di vivere quindici avventure con il mio eroe preferito, Paperino, pubblicate su Topolino e poi in volume. L’ultima storia aveva Mina protagonista. Paperica fa, in formato “paperoso”, tutto ciò che ho fatto da cronista: Sanremo, Venezia, Cannes, Nobel, Oscar… per TelePaperopoli o per il Paper Sera, a seconda dei casi».
A proposito di Mina: non concede interviste. Ci ha mai provato?
«No, sapevo che non le dava più già da prima che iniziassi il mestiere, a metà anni Settanta. Ho però curato dieci dvd per la Rai, “Mina. Gli anni Rai”: ha scelto lei le immagini preferite; i materiali sono stati poi commentati da grandi come Federico Fellini e altri. È stata una bellissima avventura, l’ho incontrata e ci ho lavorato intorno».
Qual è la forza di Mina, oltre alla voce?
«Il carattere che si fa arte e il talento che si fa carattere. Ha sempre fatto ciò che voleva, senza compromessi. Voce pazzesca, ma anche coraggio: amare chi sentiva di dover amare e vivere una vita che valesse la pena. A quasi 85 anni canta con la giovinezza di sempre: si sveglia ogni mattina con la sensibilità dei grandi artisti».
Lei ha raccontato molto di Fellini: c’è un’immagine che tiene con sé?
«Con lui ogni immagine era più bella dell’altra: raccontava l’avventura umana con limpidezza e profondità. Condividevamo la passione per i fumetti e per certe canzoni “di una volta”. Ricordo una sua frase: “È la curiosità che mi fa alzare la mattina”. E una canzone, “Volano le canzoni” di Nicola Piovani e Vincenzo Cerami, scritta alla morte di Fellini: meravigliosa».
La prima volta in Rai?
«Il 25 febbraio 1980: il giorno dell’assunzione. Entrai e vidi i volti del telegiornale: Massimo Valentini, Emilio Fede, Paolo Valenti, Bruno Vespa… Il mio maestro fu Lello Bersani; il vicedirettore era Nuccio Fava, un grande notista politico. Avevo una gran voglia di imparare. Lavorai subito in due redazioni, Esteri e Spettacolo. È stata una bellissima avventura giornalistica, sempre da cronista».
Ha detto che ha sempre intervistato solo chi amava. Ma chi è stato il più difficile da amare?
«I grandi mi hanno insegnato umiltà: ascoltare, capire, poi raccontare, con passione e fatica. Qualcuno più spigoloso c’è stato. Ricordo Kevin Costner: la prima volta fu dopo gli Oscar, fu antipatico, glissava sul suo passato italiano; ebbi l’impressione di scortesia. La seconda invece, a Milano, parlò di cotolette, risotto, la città: fu simpaticissimo. Le persone cambiano col contesto».
Me lo racconta un aneddoto che non ha mai raccontato?
«Ce n’è uno con Diane Keaton. Era a Cannes per il documentario “Paradiso”: ero l’ultimo di una lunga lista di intervistatori, lei fu gentilissima. Doveva essere un’intervista di cinque minuti, durò mezz’ora, tra tè e pasticcini: parlò con serenità di tutto, soprattutto di un “paradiso” come luogo di pace da cercare».
Sanremo: qual è stata l’edizione più folle da inviato?
«Tutte. Ogni Festival ha una dinamica unica: dipende dal direttore artistico, dai cantanti, dai giovani, dagli ospiti, perfino dai costumi. È una festa popolare nazionale, con la sua “follia” e allegria. Le canzoni, a volte, ti restano in mente e non le togli più. Con Pippo Baudo ho fatto tredici Festival: un grande conduttore. Una volta Mike Bongiorno mi propose la direzione artistica; gli risposi: “Grazie, Mike, ma faccio il mestiere di cronista: è molto meglio”».
Tra i suoi primi servizi al Tg1 c’è De Gregori, ricorda?
«Sì: De Gregori e Nanni Moretti. De Gregori è un poeta che seguo dal primo album, “Theorius Campus”, con Venditti. “Alice” mi folgorò; “Santa Lucia” la considero preziosa “per tutti quelli che hanno un cuore che non basta agli occhi”. Feci io il video de “La donna cannone”, usando immagini d’archivio e manifesti delle donne cannone raccolte in un libro che ho comprato a Los Angeles. I discografici cercavano un video più cinematografico, risposi che se volevano un video “ortopedico” potevano andare altrove».
Ligabue la definisce un «amico fraterno», perché?
«Perché l’ho seguito dall’inizio, da «Balliamo sul mondo». Era giovanissimo quando venne al Concerto del Primo Maggio: io presentai le prime quattro edizioni. Tra una pausa e l’altra parlavamo di libri e musica. Mi piace la sua scrittura letteraria e il suo modo diretto di stare con i fan. Un incontro bello, che continua a esserlo».
Se potesse portare a cena tre artisti: Totò, Troisi, Sordi. Chi sceglierebbe?
«Non lascerei a casa nessuno. Totò: gli ho dedicato sette anni di lavoro e ho pubblicato per la prima volta le sue canzoni. Sono più di 47, non c’è solo “Malafemmena”. Troisi: un grande amico, l’ho seguito da “Ricomincio da tre”, momenti epocali. Sordi: voce splendida, gli ho raccolto le canzoni e gli ho dedicato una serata allo Stadio Olimpico, “Premio Colonna Sonora”, con Enzo Jannacci. Tre miracoli italiani».
Le va di ricordare James Senese, che ci ha lasciato da poco?
«Un gigante. Con quella voce apparentemente lieve ma profonda come una caverna, suonava e cantava con l’anima. Quando arrivava sembrava venire da un mondo lontano e vero: non fingeva mai, non aveva bisogno di accorgimenti. Napoli lo ha fatto diventare un artista autentico, non un prodotto di marketing. Ha gettato radici profonde: ne sentiremo gli echi a lungo».
Dopo i problemi alla vista, ha detto: «le immagini mi arrivano dalla memoria». Quale non vorrebbe che si cancellasse mai?
«Se potessi riavere due ore di sguardo, rivedrei mia moglie, Rosa Maria, e mia figlia Caterina. Oggi posso carezzarle e sorridere, ma vorrei rivedere ancora una volta i loro occhi».