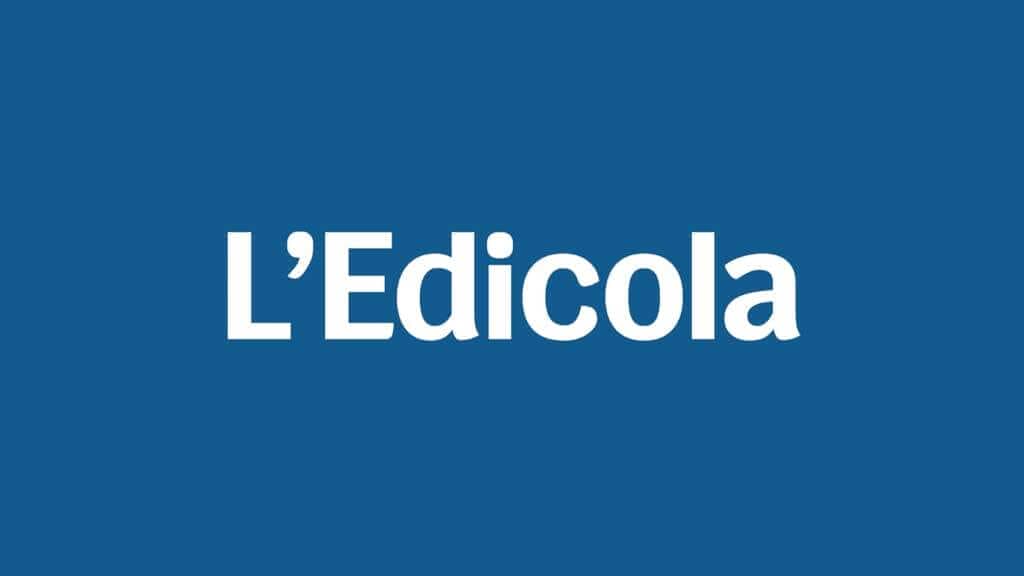Le campagne del foggiano, un tempo, erano famose per i numerosi campi di volo presenti e utilizzati, nell’ultimo conflitto bellico, sia dai tedeschi che, successivamente allo sbarco in Sicilia, dagli anglo-americani. Oggi, molte di quelle piste sono sparite, altre sono diventate moderni scali militari (come Amendola) o civili, come il Gino Lisa. Altri ancora più tristemente noti alle cronache attuali, come l’ex pista di Borgo Mezzanone, diventata simbolo del degrado e dello sfruttamento di manodopera nelle campagne del foggiano, dove un tempo prendevano il volo gli aerei che lottavano per la libertà e la democrazia. Corsi e ricorsi di una storia che non è mai maestra di vita.
La situazione
È martedì 4 aprile 1944, gli alleati sono ancora impegnati sul fronte di Cassino e la liberazione di Roma è ancora lontana. In Friuli viene attivato il forno crematorio della Risiera di san Sabba. Gli alleati utilizzano anche le basi pugliesi per le prime incursioni aeree contro le raffinerie di petrolio in Romania.
In Capitanata tra gli alleati c’è fermento per i nuovi obiettivi bellici. Charles Barry da Johannesburg fa coppia con il navigatore Ian Mc Intyre, da Città del Capo, del sessantesimo Squadron di ricognizione fotografica della South African Air Force, prendono posto sul moderno e veloce De Havilland Mosquito IX, sulla pista del campo di volo di san Matteo a pochi chilometri da San Severo. Hanno da compiere una missione di ricognizione in terra polacca: devono fotografare l’attività «del grande impianto Buna-Werke» attivo «nella produzione di gomma sintetica della compagnia tedesca I.G. Farben». Si trattava del più grande stabilimento chimico del mondo. «Proprio nel 1944, la I.G. Farben utilizzava il lavoro di oltre ottantamila deportati. Gli anglo-americani erano al corrente dell’esistenza del grande impianto Buna-Werke e pur avendo qualche dubbio in merito alla sua effettiva funzione avevano comunque deciso di bombardarlo, di distruggerlo», scrive Gigi Iacomino nella sua ricostruzione degli eventi.
La missione
Per i due piloti sudafricani l’ordine è preciso: devono effettuare un lungo volo, solitario e senza scorta, a bordo della loro “meraviglia di legno”, fino ai cieli della Polonia meridionale «per fotografare con la massima precisione possibile la grande fabbrica tedesca I.G. Farben di Monowitz», uno complesso produttivo non molto distante da Auschiwitz. Quasi 5 ore di volo e oltre duemila chilometri di distanza tra andata e ritorno.
Il racconto
Iacomino nella sua relazione lascia parlare uno dei protagonisti. «Scriverà Charles Barry nel 1989, quarantacinque anni dopo: “Se mi ricordo bene, io e Ian ci avvicinammo all’obiettivo da fotografare volando da ovest verso est e lui mi avvertì che il portello della macchina fotografica non funzionava a dovere. Dovevamo fare in fretta poiché il nostro aereo di ricognizione era disarmato e correvo il serio rischio di essere intercettato dal nemico. Impegnarci in un secondo giro di ricognizione, dunque, sarebbe stato pericoloso. Ciononostante, invece di tornare indietro, decidemmo di avvicinarci nuovamente all’obiettivo. Ian lasciò la macchina fotografica in modalità di ripresa per un tempo più lungo del solito e penso che fu proprio questa corsa supplementare che consentì di riprendere particolari di quel campo di concentramento che in seguito sarebbe stato conosciuto come Auschwitz». Particolari che resteranno nascosti per quasi 50 anni.mau.tar.