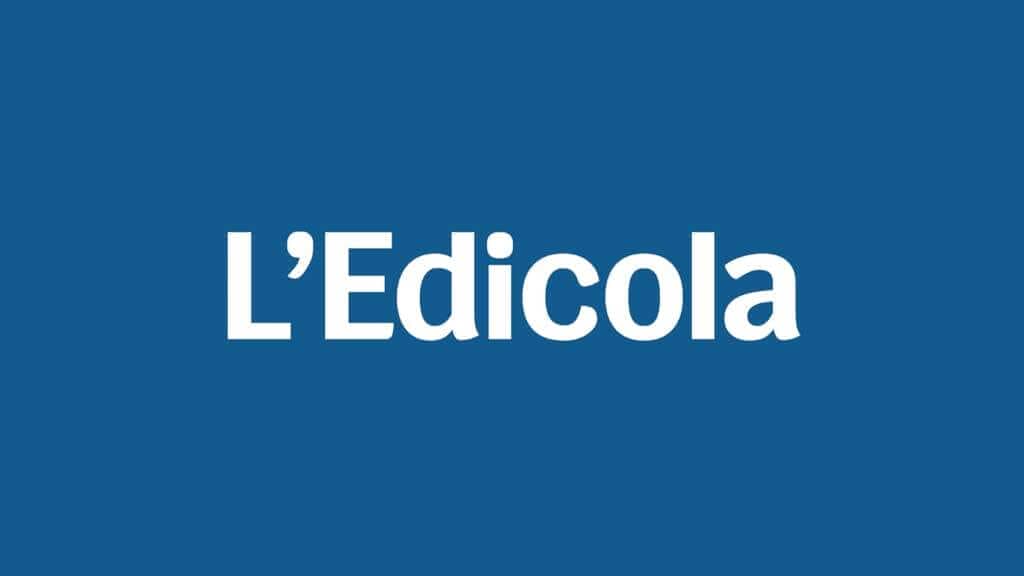Fosse nato nel Rinascimento, Escher avrebbe avuto un posto tra Piero della Francesca e Leonardo. Non per la pittura – che non era la sua materia – ma per quella febbre matematica che porta la mente a vedere nella forma un assoluto. Al Castello Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano, fino al 28 settembre, ottanta opere rivelano la sua ossessione: dominare lo spazio fino a renderlo prigioniero di se stesso, costruendo mondi nei quali l’occhio crede e il cervello vacilla. Non si viene qui per ammirare un decoratore dell’impossibile, ma un filosofo dell’immagine, un architetto dell’infinito che, come i maestri di Urbino o i geometri greci, trasforma la percezione in dimostrazione. Conversano, dopo Ligabue e Chagall, si sta misurando con un genio che ha più a che fare con Euclide e Platone che con l’arte da salotto. E la Puglia lo accoglie come merita, con un percorso rigoroso e seducente, dove ogni sezione è un capitolo di una teoria generale della visione.
Architetture dell’infinito
Il viaggio comincia con i primi anni olandesi e le xilografie liberty di fiori e insetti: un apprendistato minuzioso, guidato da Samuel Jessurun de Mesquita. Poi l’Italia: San Gimignano, la Sicilia, l’Abruzzo, la Calabria. Paesaggi che Escher trasfigura in costruzioni mentali, come se ogni collina fosse un teorema, ogni scorcio una variazione prospettica. È qui che la luce italiana, severa e limpida, si fonde con la sua inclinazione al calcolo, anticipando i paradossi futuri. Il 1936 segna la rivelazione: l’Alhambra di Granada, le decorazioni moresche, la scoperta della tassellatura perfetta. Figure geometriche che si ripetono all’infinito, trasformandosi in pesci, uccelli, rettili, cavalieri. È l’ordine assoluto che si fa immagine. Nascono così “Giorno e notte”, “Cielo e acqua”, “Incontro”: metamorfosi continue, senza un inizio né una fine. Qui la bellezza non è un colpo d’occhio, ma un processo, una deduzione che chiede lentezza, come leggere Euclide o attraversare Dante. Dalla tassellatura alla struttura dello spazio: sfere che riflettono il mondo, nastri di Möbius che annullano il concetto di fronte e retro, solidi geometrici che sembrano usciti da un trattato di Archimede e invece appartengono a un sogno lucido. Nei paradossi geometrici – “Belvedere”, “Cascata”, “Relatività” – l’inganno è perfetto: ciò che si vede è plausibile e insieme impossibile. L’allestimento moltiplica gli sguardi: video, modelli tridimensionali, sale ammiccanti in cui la percezione si allarga e si restringe, costringendo il visitatore a dubitare di ciò che credeva certo.
Un’eresia necessaria
Le ultime sale raccontano l’Eschermania dagli anni ’50: la consacrazione scientifica, l’appropriazione hippy, la diffusione pop. Eppure, anche nelle magliette psichedeliche o nelle citazioni cinematografiche, l’arte di Escher rimane inespugnabile, aliena alla banalità dell’uso. Non si lascia ridurre a logo: è un enigma che resiste, come i poliedri incisi nelle tavole di Pacioli. Nel tempo delle immagini lampo, in cui la velocità è scambiata per intelligenza, Escher rappresenta un’eresia: chiede attenzione, chiede tempo. Guardare le sue opere è come leggere una partitura di Bach: ogni elemento ha un posto, ogni intervallo ha un senso, e nulla può essere alterato senza compromettere l’insieme. È l’eco di un pensiero che continua a lavorare nella mente: la certezza che lo spazio non sia mai innocente, che ogni linea possa nascondere un inganno, che la prospettiva sia un atto di fede. Escher, come un teologo della forma, ci consegna un dubbio assoluto: che la bellezza, quando è vera, non consola, ma inquieta. È in questo turbamento che si misura la grandezza di predestinato condannato a non finire mai.