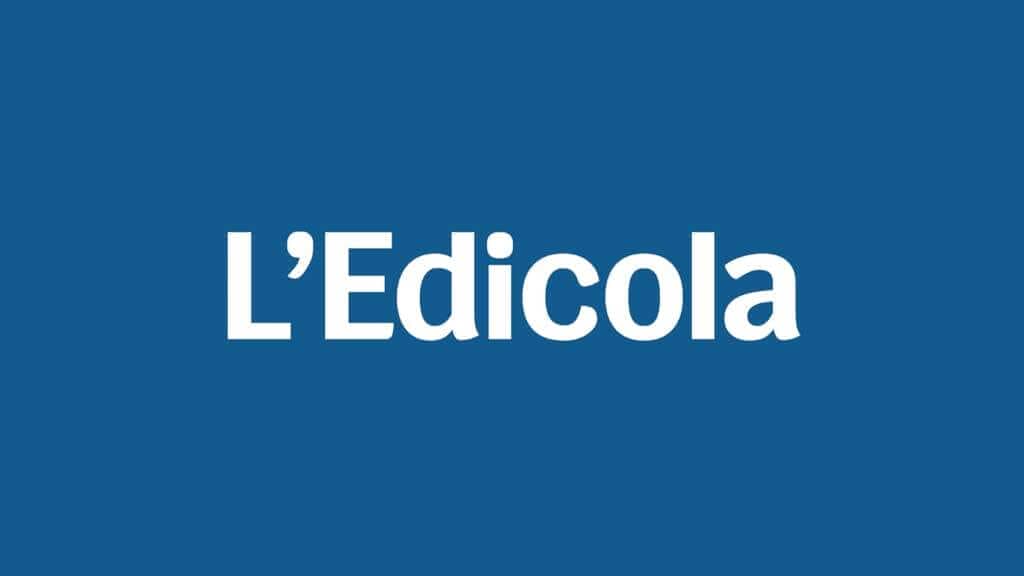L’innovatività di un progetto di ricerca e sviluppo (R&S), ai fini del credito di imposta 2015–2019, va valutata con riferimento alle conoscenze disponibili per l’impresa, e non per il mercato nel suo complesso. A chiarire questo principio è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1482/2025 depositata il 16 giugno 2025 intervenuta in merito alle spese sostenute da una società contribuente, in forza dei progetti descritti e qualificate come attività di R&S ai sensi dell’articolo 3 del D.l. 145/2013.
Il caso
A una società veniva prima inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate un questionario relativo a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, un atto di recupero con cui le veniva contestato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, alla luce dei cinque criteri stabiliti nel manuale di Frascati 2015: novità per il mercato (e non per la singola impresa); creatività; incertezza; sistematicità; trasferibilità.
Contestualmente veniva irrogata sanzione del 100% dell’importo dei crediti ritenuti inesistenti utilizzati in compensazione. A partire dal 2020 il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa, che effettuano investimenti in attività di R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative.
Vi è poi un credito specifico a beneficio delle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori alternativo al credito R&S. La sentenza richiama le linee guida del ministero delle Imprese relative alla certificazione del credito d’imposta, che da un lato confermano la necessità di applicare le definizioni previste dal manuale di Frascati sia alle attività di R&S effettuate nel periodo 2015-2019 che a quelle relative al periodo d’imposta 2020 e, dall’altro, suggeriscono di ricomprendere nella nozione di ricerca e sviluppo “anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per l’impresa”.
Con la pronuncia in commento la Corte di giustizia tributaria ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente e ha sancito la illegittimità dell’operato dell’Ufficio per avere adottato un’interpretazione restrittiva del concetto di “innovatività”, riferita al solo livello di conoscenze presenti in un determinato settore anziché al patrimonio di nozioni e conoscenze a disposizione del soggetto che ha sostenuto gli investimenti. Tale approccio è risultato incompatibile con la disciplina normativa interna, volta a favorire il progresso dei processi esistenti, che impone di valutare lo sforzo innovativo in senso relativo alla luce “dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa”, tenuto conto che la nozione di R&S rilevante ai fini della fruizione del credito d’imposta implica un “apprezzabile elemento di novità” e non già una novità in senso “assoluto”.
Le precisazioni
Con la sentenza si ribadiscono altri due principi rilevanti: l’Ente creditore avrebbe dovuto preliminarmente chiedere parere al MISE, prima di procedere al recupero del credito d’imposta asserito inesistente, attesa la complessità dell’attività di R&S. La nozione di “credito inesistente”, alla luce delle nuove definizioni introdotte nell’articolo 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies del D.lgs. 74/2000, implica una situazione fittizia (mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi) ovvero una rappresentazione decettiva (i requisiti presenti formano oggetto di rappresentazioni fraudolente), del tutto assenti nel caso di specie, avendo la Corte appurato l’esistenza e l’effettività dei progetti realizzati dalla società contribuente. La sentenza ha il pregio di offrire un importante spunto interpretativo, perché consente di superare il requisito della “novità” intesa in senso assoluto.