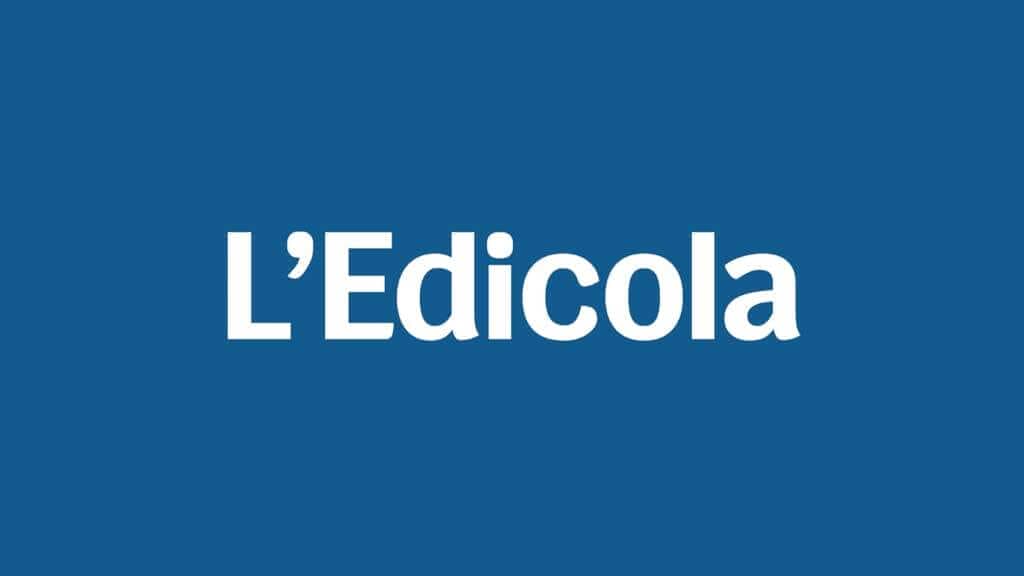In Strike – Figli di un’era sbagliata, opera prima dei registi Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, tre ragazzi trascorrono un’estate dentro una struttura sanitaria per chi affronta dipendenze patologiche. Fra dialoghi serrati, scarti di comicità e momenti più duri, il film racconta le fragilità della generazione di oggi senza giudicarla. Nato come spettacolo teatrale e ora presentato fuori concorso al 43esimo Torino Film Festival, Strike porta sullo schermo ambienti e situazioni che i tre autori hanno studiato da vicino. In questo mondo complesso entra anche la dottoressa Marzioni, interpretata da Matilde Gioli. L’abbiamo incontrata a Torino.
Qual è il suo personaggio nel film?
«Interpreto la dottoressa Marzioni, una psicologa che lavora nella struttura dedicata ai ragazzi con dipendenze patologiche. È un ruolo che mi ha subito colpita, soprattutto per il rapporto con Ceccherini, che nel film è il capo del dipartimento psicologico. Lui è proprio il “genio e sregolatezza” della psicologia: ha intuizioni istintive, molto belle nel modo di prendere i pazienti, ma si porta dietro una certa confusione che qualcuno deve rimettere in ordine. Quel qualcuno, nella storia, sono io. Ci compensiamo. E per me è stato anche un modo per realizzare un desiderio d’infanzia: da piccola sognavo di fare la psicologa o il medico, quindi indossare quel camice è stato davvero bello».
Il film affronta un tema enorme e delicato: la dipendenza. Che percezione ha, anche nel mondo del cinema, del rapporto tra giovani e sostanze?
«È un argomento che mi ha sempre toccata molto, anche se personalmente non ho avuto problemi di dipendenza, né li ho avuti in famiglia. Eppure qualcosa mi fa empatizzare profondamente con chi soffre di tossicodipendenza. Credo sia iniziato tutto quando ero negli scout: facevamo attività in una comunità e io, invece di occuparmi dell’animazione, finivo sempre a parlare con i ragazzi. Mi avevano colpita per la loro umanità, erano anime perse. Non capivo come una sostanza potesse avere un potere così forte su una persona. Da allora ho continuato a informarmi, leggere, guardare interviste, parlare con medici e psichiatri. Non è un’attrazione morbosa, è che non mi sembra reale che sia così difficile uscirne. Il meccanismo che si innesca è maledettamente difficile da scardinare, e questa cosa mi manda fuori di testa».
Le dipendenze stanno cambiando soprattutto tra i giovanissimi.
«Purtroppo lo vedo anch’io. Tra i giovanissimi c’è una diffusione enorme di ketamina, crack e droghe molto più pesanti, completamente fuori controllo. È una dinamica sociale che andrebbe attenzionata molto più seriamente rispetto a quanto si stia facendo oggi».
Il film non spettacolarizza le dipendenze, le mostra come «tentativi di stare con qualcuno». Era un obiettivo preciso?
«Sì, assolutamente, la volontà è proprio quella: non spettacolarizzare né rendere pauroso il tema. Spesso nel film c’è leggerezza, persino comicità, per umanizzare la dipendenza e renderla avvicinabile. La tendenza comune è avere paura di questi temi, invece così diventano più comprensibili e più vicini».
Come si esce da una dipendenza?
«È un percorso complessissimo, per chi lo vive e per chi gli sta accanto. A volte sembra di lavorare tanto senza vedere mai risultati: possono passare anni. Poi, improvvisamente, scatta qualcosa. Forse un istinto di sopravvivenza, non lo so. La persona decide che vuole vivere. Ma basta una cavolata per ricaderci dentro. Serve una forza e una pazienza sovrumane. Non ho consigli da dare — non credo di poterlo fare — ma sono molto solidale con chi soffre, e soprattutto con i familiari. Per loro è veramente una vita infernale».
Una battuta su Torino?
«Mi piace molto, lo dico spesso anche perché sento molte persone che si trasferiscono qui, studenti e non solo. È un centro nevralgico, avverto sempre grande entusiasmo in chi la vive. Anch’io mi sono trovata molto bene. È una città a misura d’uomo, con belle vibes, come direbbero i giovani: tranquillità, pacatezza, eleganza. Mi riprometto di tornare qui con calma».