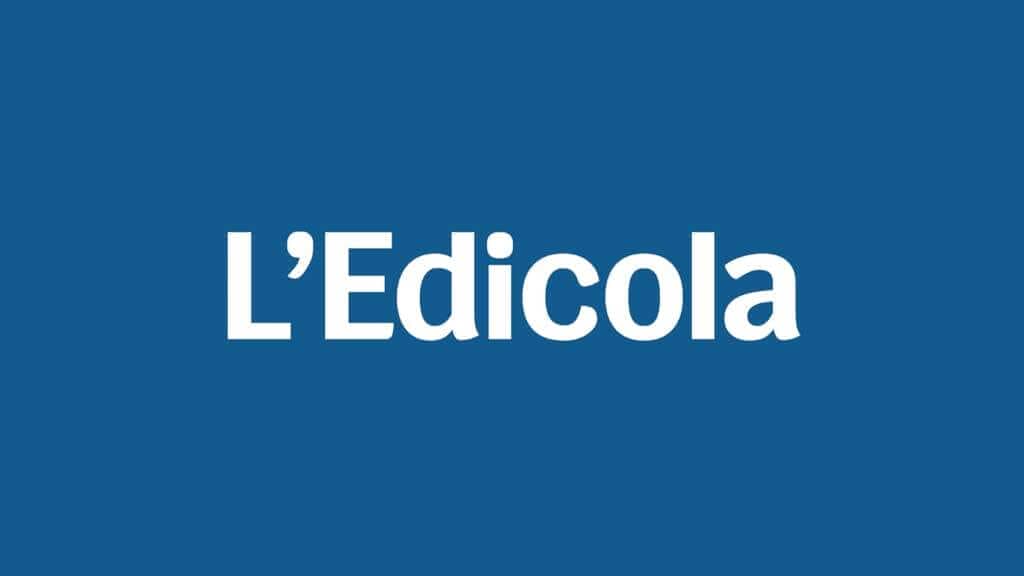«Se io ti do un’idea e tu me ne dai una, alla fine ne abbiamo due». È un proverbio cinese apocrifo, trasmessogli dal padre, a guidare Antonio Monda nella costruzione del suo Incontri ravvicinati (La nave di Teseo), un libro che è insieme memoria, manifesto e gesto d’amore verso il confronto. Non si tratta solo di una galleria di ritratti – da Philip Roth a Marina Abramović, da Scorsese a David Foster Wallace – ma del racconto di un metodo, di un’etica del dialogo: aprire le porte, ascoltare, lasciarsi trasformare. Nella New York dove vive da oltre trent’anni, Monda ha ricreato la casa della sua infanzia: non un salotto mondano, ma un rifugio in controtendenza, dove si discute, si canta, si ride, si sprofonda. La leggerezza come via alla profondità, la curiosità come vocazione morale. Il libro è anche un’ode alla città che lo ha accolto – crocevia di lingue, dolori e rinascite – e un atto di fedeltà a chi lo ha formato: «Non restare nel tuo orticello», diceva sua madre, spingendolo verso l’altro e l’altrove. A chi gli chiede cosa rimanga di un incontro, Monda risponde senza esitare: un arricchimento. E forse, con un po’ di fortuna, anche un’amicizia.
Il libro si apre con l’immagine della casa: non solo un luogo, ma un centro vitale di scambio. Come si costruisce, oggi, uno spazio simile?
«Forse il motivo per cui questa casa ha avuto successo è che va in controtendenza rispetto a ciò che propone il mondo contemporaneo. Il New York Times l’ha definita “l’ultimo salotto culturale di New York”. Ma non è solo un salotto: è un rifugio. Sono cresciuto in una casa così, grazie ai miei genitori. La base del nostro spazio è sempre stata quella dell’accoglienza, della libertà, dell’assenza di giudizio. E anche un po’ di leggerezza, perfino di gioco. Fin dall’inizio, abbiamo voluto che fosse un luogo dove si potesse cantare, chiacchierare, pensare. Insieme».
Che cosa ha trovato a New York che non ha mai trovato in Italia?
«New York ha una struttura unica. Una città nata per accogliere, è un melting pot autentico. Ci sono centocinquanta tradizioni culturali che convivono. E poi New York è potere economico. Dove c’è economia, fiorisce la cultura. Anche nei momenti più duri, hai sempre la sensazione che tutto nasca o passi da lì. E questa sensazione non ce l’hai in nessun’altra città al mondo».
Nel libro lei ha escluso sistematicamente il pettegolezzo. Una scelta etica?
«Assolutamente. Ho evitato il gossip, anche se potrei raccontarne molti. Non è solo questione di eleganza, ma di rispetto. Ogni incontro mi ha lasciato qualcosa. E spero di aver lasciato qualcosa anch’io a loro. È un privilegio. Una benedizione, davvero».
C’è qualcuno che non le è stato particolarmente simpatico dei personaggi che ha incontrato?
«Gore Vidal. Brillante, intelligentissimo, colto. Ma supponente. Diceva che la felicità sta nel vedere l’insuccesso degli amici. E quando morì Truman Capote, commentò con una battuta dicendo “Ottima mossa per la sua carriera”. Questo era il personaggio».
E al contrario, c’è qualcuno a cui si è sentito legato umanamente?
«Più di uno. Ma Martin Scorsese, su tutti. Gli devo moltissimo. Per la sua intelligenza, la sua generosità, il nostro dialogo continuo sulla fede, molto presente nel suo cinema seppur sottovalutato. Poi Donna Tartt, Nathan Englander. Con loro c’è una sintonia profonda».
Il dolore torna spesso come tema. Quanto contano empatia e ascolto, per chi scrive ritratti?
«Sono tutto. Se non si ascolta, se non si entra in sintonia, se non si sente il dolore dell’altro, non si può fare nulla. Nemmeno iniziare un dialogo. L’empatia è la base».
Alcune amicizie non le ha volute raccontare. Perché?
«Perché l’intimità viene prima dell’ambizione artistica. Io penso il contrario di Aristotele: metto l’amicizia davanti alla verità. Lo dico senza ironia».
Ha dedicato parole intense a Philip Roth, David Foster Wallace e Marina Abramović. Cosa hanno in comune?
«Una curiosità intellettuale instancabile. Wallace poteva parlare con la stessa lucidità di Camus come di Federer. Roth era un gigante. Talentuoso, ma anche generoso. Gli è stato negato il Nobel per motivi ignobili, come le accuse infondate di antisemitismo, di misoginia. Marina è un altro pianeta: potentissima e semplicissima. Quando viene da noi a cena, finisce sempre in cucina a controllare le ricette».
Ha scritto che la leggerezza può condurre alla profondità. Ma non è un rischio, oggi più che mai?
«Se diventa superficialità, sì. Ma se è un viatico per entrare nel dettaglio, nell’atomo, allora no. La leggerezza è un mezzo per andare in profondità, se la si sa usare».
Questo libro sembra anche una dichiarazione d’amore per il confronto. In tempi segnati da diffidenza, si sente un testimone fuori moda?
«Le cito Malraux: diceva che De Gaulle era un uomo dell’altro ieri e del dopodomani. Ecco, con molta umiltà, mi riconosco in questa idea. Qualcosa di antico, forse, ma anche qualcosa che verrà».
C’è un aneddoto che le piace particolarmente ricordare?
«Una volta andai a casa di Isaac Bashevis Singer, lo trovai a litigare con la moglie perché lei aveva perso il diploma del Nobel. E poi, quando intervistai Barbra Streisand, feci lo sbruffone dicendo che avevo già parlato con Singer. Non sapevo che aveva scritto il racconto da cui è tratto “Yentl”, che lui definì un film orribile. Lei mi cacciò. Letteralmente (ride, ndr)».
Qual è il personaggio che ha lasciato il segno più profondo in lei?
«David Foster Wallace. Gli ho voluto bene, credo che anche lui me ne volesse. La sua morte ha lasciato un buco enorme».
C’è qualcuno che avrebbe voluto conoscere e non ha potuto?
«Churchill, Hemingway e Borges che adoro. E Cormac McCarthy: ci ho provato, gli chiesi un’intervista, ma non me la concesse».